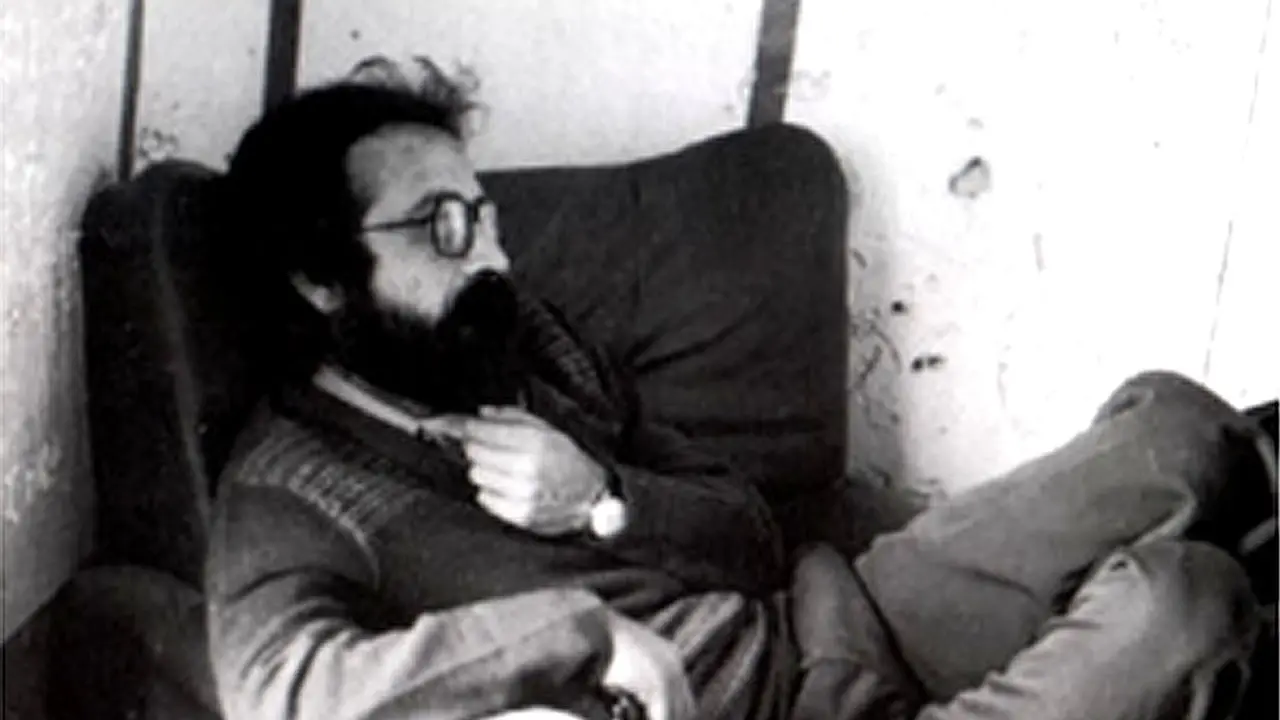Tutti gli articoli di Blog
PHOTO
Sono un po’ di anni che ci si costringe a un nove maggio di torrenziale difetto di informazione commemorativa su Aldo Moro e Peppino Impastato, due storie che non potrebbero essere più diverse, accomunate da una data e da un anno di morte, da un contesto storico e da un dramma umano. Non dagli altri equilibrismi che si è soliti sentire in giro. Quest’anno gli editorialisti prezzolati erano per fortuna (ma fino a un certo punto) impegnati con enciclopediche dissertazioni sul Covid o con esercitazioni di ordine pubblico e carità sul caso di Silvia Romano.
Aldo Moro è stato un giurista, uno statista e un uomo politico. Tra chi lo ha conosciuto, c’è ancora il ricordo del saper fare autocritica sulle proprie scelte sbagliate, del non aver vissuto nell’ampolla agiografica dell’autocompiacimento. La mitizzazione postuma ha finito per oscurare tanti, troppi, aspetti, caricaturalizzando peraltro tutti quelli collettivamente positivi. Il Moro autenticamente austero, di una politica poco presenzialista, di un’etica pubblica antiprivilegiaria, viene sovente salutato senza nessun esercizio di attualizzazione. E anche l’immagine del cd. “compromesso storico” tra il Partito Comunista Italiano e la Democrazia Cristiana è resa a una sola dimensione.
La verità è che quel compromesso era divenuto ormai politicamente inevitabile e per il PCI fu tuttavia un abbraccio complicato. Inevitabile, perché la sistematica esclusione dalle maggioranze di governo di un terzo dell’elettorato, che esprimeva enti pubblici e intellettualità oltre che dirigenza diffuse, non era fisiologicamente possibile, nemmeno per un Paese abituato a dormire sui vizi del proporzionale e restio a incoraggiarne in realtà gli aspetti meritori (ivi compresa, una fotografia un po’ più fedele e un po’ meno restia del corpo elettorale).
Complicato per il PCI, tuttavia, che sposò una linea troppo spesso acriticamente contraria agli ancora vasti movimenti extraparlamentari che agivano dentro un’idea rivoluzionaria, socialista, antiautoritaria della cosa pubblica. Quel PCI si arroccò alla sua destra e alla sua sinistra. Fu determinante per sconfiggere l’eversione, ma se quello era il male la cura fu un ritardo storico nel comprendere le battaglie che si muovevano nella società italiana: la crisi della classe operaia come soggettività, l’ambientalismo, l’antiproibizionismo, i diritti civili, i momenti del dissenso religioso.
Sempre il 9 Maggio del 1978 muore Peppino Impastato: non un cadavere fatto ritrovare nei quartieri romani del potere, ma un omicidio di mafia. I ragazzi delle scuole potrebbero essere portati a credere che Impastato sia stato sempre ben ricordato per il suo impegno. Daremmo loro a bere una stupidaggine. La maggior parte dell’opinione pubblica settantottina era purtroppo in altre faccende affaccendata (e comprensibilmente parimenti tragiche assai più percepite). Quelli che seppero, a lungo, coltivarono l’immagine di un Peppino sbandato. Il freak della Sicilia profonda, il vinaiolo, il ribelle smilzo che incantava le ragazze. Altro immane tappeto di fesserie.
Cinisi sapeva la matrice di quella morte; la si poteva leggere ovunque in Italia. Nessun requiem gli è stato suonato. E per due cose dovremmo un po’ meglio ricordarlo: un’antimafia basata sulla conoscenza (giudiziaria e sociale) della vera illegalità; un’intuizione micidiale sui nuovi mezzi di comunicazione. Le radio d’alternativa nei Settanta e negli Ottanta animarono la provincia di spunti, suggestioni, divertimenti – non solo drammi, non solo lazzi – che altrimenti non si sarebbero mai calati fino alla periferia dell’impero.
Il 12 Maggio dell’anno prima veniva uccisa a Roma, durante una manifestazione organizzata per festeggiare la vittoria del no al referendum abrogativo sul divorzio, una ragazza di diciannove anni, lì col suo fidanzato. Erano anni in cui ti facevano morire con un proiettile calibro 22 nell’addome. E si vede che c’entra più l’apparato che il popolo. I referendum su aborto e divorzio, per quanto accesi, furono negli anni una sana, sincera, paritaria, palestra democratica tra favorevoli e contrari. Non il referendum “andate al mare”, non il referendum “senza quorum”. Una targhetta ricorda Giorgiana Masi a Roma, lungo il fiume, a centocinquanta metri dall’accesso al rione di Trastevere.
Per chi ama Roma, tra gli angoli più belli per star lì con chi si ama. Da quelle parti un vecchio chiosco vende a prezzi popolari spuntini e bevande anche mediamente pregiate. Una sera ricordo chiesi al bangladese lì solerte al lavoro se sapeva chi fosse Giorgiana Masi, neanche vent’anni di quieta bellezza e fresca voglia di coscienza civile spazzati via con pochi millimetri di piombo. L’uomo mi rispose con grande ardore, molta aneddotica e tanta accoratezza infarcita anche di un buon linguaggio corretto. E lì mi capitò sinceramente di sentirmi orgoglioso di essere italiano: un sentire che spesso gli illeciti e i morti, i crimini e le frodi, i corifei e gli sciocchi, ci impediscono di provare.